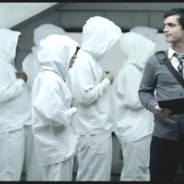Articoli
Stomia: sessualità e persona (3 di 3)
LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL PROBLEMA: FUNZIONI, RESPONSABILITA’ E PRASSI L’operatore sanitario all’interno della relazione con il paziente è sempre rapportato con un gruppo di lavoro ed un’istituzione che sono il contesto ed il “contenitore” entro il quale spende capacità professionali e relazionali. In particolar modo, lavorando con pazienti stomizzati, parte integrante del programma terapeutico dovrebbe essere costituito da: Una corretta informazione pre-operatoria che possa prospettare anche le conseguenze successive all’intervento e gli effetti collaterali. La presa in carico del paziente da parte di un’equipe multidisciplinare (chirurgo, infermiere, stomaterapista) per quanto riguarda la fase pre e post-operatoria e la successiva applicazione e convivenza con la stomia. L’aiuto a reintegrare nella propria identità lo schema corporeo, l’elaborazione dei cambiamenti e la possibilità di poter continuare a vivere una vita piena. Il lavoro dell’operatore, all’interno dell’istituzione sanitaria, non è dato solo dalla collaborazione consapevole tra professionisti, ma anche dai legami inconsci che spesso intervengono nell’ambito della produttività: medici, infermieri, stomaterapisti, esercitano il proprio mandato all’interno di un’istituzione che prevede regole e statuti specifici nell’ambito della cura della malattia, con i quali devono fare i conti sia singolarmente, sia come parte di un gruppo di lavoro. L’equipe non è solo la somma di ruoli e funzioni, ma un insieme di esperienze, affetti, rappresentazioni comuni dotato di una storia, di una memoria affettiva ed una progettualità condivisa. Il curante si trova quotidianamente a contatto con incontri, rapporti ed eventi che stimolano la riflessione e lo mettono di fronte alla malattia (ed alle limitazioni ad essa connesse), alla sofferenza ed a volte alla morte: temi sui quali spesso pazienti e familiari chiedono di avere risposte, spiegazioni e di trovare un senso ed un nome che plachi le proprie paure rispetto a quanto sta loro accadendo. Il gruppo dei curanti acquisisce, in questo senso, anche un ruolo pedagogico e contenitivo. Il paziente ha bisogno di qualcuno che lo accompagni aiutandolo a comprendere ciò che gli sta accadendo; il malato necessita di un interlocutore che non può più essere solamente il medico, ma tutta l’equipe multidisciplinare, per questo sono fondamentali i rapporti all’interno del gruppo di lavoro e con l’istituzione. E’ importante che il paziente sia messo nella condizione di con-dividere, che significa avere un rapporto con i curanti che lo aiutino a capire e vivano con lui ciò che sta accadendo. Questo necessita che l’equipe multidisciplinare sia strutturata come un gruppo di lavoro capace di maternage, ovvero la capacità della mente di accogliere e contenere l’altro. Lavorare in questo modo con il paziente ed i familiari, significa aiutarli anche ad acquisire altri punti di vista e nuovi significatio in merito alla malattia, agli interventi, alle terapie, all’eventuale stomia: non solo osservare ciò che è “rotto”, ma sviluppare la capacità di vedere ciò che ancora si può realizzare nonostante la presenza della malattia e delle limitazioni ad essa connesse. Come affrontato in precedenza, il paziente vivendo una situazione particolarmente ansiogena come quella della patologia e della conseguente applicazione di una stomia, struttura sovente meccanismi psichici di tipo regressivo, sviluppando bisogni spesso basilari, ma di grande importanza per lui: come il bisogno di sentirsi accudito, compreso, toccato, ma soprattutto il bisogno di percepirsi all’interno di un gruppo di curanti che non si spaventano di fronte alla sua condizione e con i quali può condividere profondamente questo momento...
read moreStomia: sessualità e persona (2 di 3)
PATOLOGIA NEOPLASTICA E MODIFICA DELLO SCHEMA CORPOREO: LA RELAZIONE D’AIUTO, STRUMENTO PER FACILITARE IL PROCESSO DI COPING La relazione supportiva tra operatore sanitario e paziente si fonda sul dialogo e sull’ascolto: offrire aiuto significa possedere delle competenze per riconoscere nell’altro bisogni spesso inespressi, così come la madre dà un nome alle emozioni del suo bambino. Lo strumento fondamentale del lavoro del curante è la relazione umana: l’efficacia clinica non si esplica solo nel saper fare, ma soprattutto nel saper essere nel rapporto con il paziente. Relazionarsi è primariamente comunicazione: parole, gesti, pensieri ed attenzioni tra il curante e il paziente (spesso veicolate dal contatto fisico), i curanti somministrano sé stessi attraverso la loro capacità di ascoltare, capire, calmare e rispondere. All’interno della relazione supportava, l’operatore sanitario deve sviluppare la capacità di ascoltare e sentire le proprie emozioni positive e negative che non vengano “sedate”, ma divengano elemento importante di valutazione della relazione stessa, da parte del professionista. Questo permetterà all’operatore di acquisire gradualmente la giusta distanza relazionale tra sé ed il paziente (differente in ogni rapporto) per potergli essere maggiormente di aiuto e supporto. La relazione supportava è una relazione professionale nella quale una persona deve essere assistita per operare un adattamento personale ad una situazione di difficile adattabilità come la malattia e le conseguenti modificazioni corporee (come una stomia). Questo richiede all’operatore sanitario di: comprendere il problema e la situazione di patologia di quel particolare paziente ed aiutarlo ad evolvere verso il suo migliore adattamento sociale. Per questo all’operatore sanitario è richiesta una preparazione tecnica e scientifica accanto a quella umanistica volta alla relazione supportava, un’apertura interpersonale, una riluttanza ai pregiudizi, la capacità di distinguere aspetti di sé e aspetti appartenenti all’altro. La relazione supportiva deve tenere innanzi tutto conto: del contesto, delle persone coinvolte, del fattore temporale, degli strumenti utilizzati. Tutti questi aspetti contribuiscono a formare il rapporto di fiducia tra paziente-famiglia ed operatore e ad incrementare l’alleanza terapeutica. La malattia grave riduce l’autonomia dell’individuo, quindi la relazione supportiva non può prescindere dal grado e dal tipo di deficit del paziente, dal fatto che sia ancora autonomo o dipenda da altri, dallo stato di avanzamento della malattia e dal fattore temporale (aspettative di vita, tempo dedicato). Naturalmente in primo piano sarà anche il contesto entro il quale si sviluppa la relazione: l’ospedale, il domicilio, o l’hospice. L’operatore sanitario deve anche essere in grado di crearsi un quadro delle persone coinvolte nella situazione di malattia: il paziente (età, status sociale e culturale, se vive da solo oppure no), il tipo di famiglia (legami vigenti e presenza o meno di bambini), il tipo di care giver (figura particolarmente importante se si tratta del partner in caso si affrontino limitazioni corporee legate ad una stomia e conseguanti modificazioni della sessualità). I sentimenti che spesso il paziente porta all’interno della relazione supportiva sono: Il timore per il cambiamento che il paziente percepisce di subire, a partire dal proprio corpo che fatica a riconoscere ancora come proprio. La trasformazione del suo modo di relazionarsi, di pensare, di sentire gli eventi della vita; questo lo rende spesso più estraneo e incomprensibile agli altri, anche alla persone più vicine ed intime. Il malato non si riconosce più nel mondo di sempre, spesso cambiano i suoi rapporti con il partner, la famiglia ed il...
read moreStomia: sessualità e persona (1 di 3)
LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA NELLA POPOLAZIONE STOMIZZATA E INCONTINENTE La sessualità si colloca nella quotidianità di ciascuno di noi come elemento e spinta fondamentale per la realizzazione di sé, della propria identità e della propria storia. Parlare di sessualità significa affrontare degli aspetti di sé molto profondi e quando il tema della sessualità si incontra con quello di malattia, emergono in primo piano i concetti di esperienza del limite insieme a quello di creatività che sono parte integrante dell’identità. La sessualità ha a che fare con il senso di soddisfazione, di pienezza esistenziale e con il rafforzamento dell’autostima: tutti aspetti centrali nella formazione della propria identità. Ma parlare di sessualità significa anche affrontare ed uscire dai non detti, dai timori e dalla vergogna che spesso accompagnano questo aspetto della vita. Quando sussiste una situazione di malattia, quest’ultima funge da amplificatore della consapevolezza del senso del limite, che diviene gradualmente presente nella percezione di sé e delle proprie relazioni sociali, affettive e sessuali. Spesso i rapporti affettivi assumono un diverso senso in presenza di una malattia (che potrebbe portare a modificazioni corporee come una stomia), della progettualità modificata, della sofferenza fisica. Il percorso successivo al cambiamento parte proprio da questi limiti, ma potrebbe gradualmente far arrivare alla scoperta della propria identità modificata, alla creatività, all’acquisizione di una capacita di intimità con l’altro rinnovata. In situazioni di precarie condizioni di salute la sessualità, in quanto attività sessuale, comincia a subire delle modificazioni fisiche e mentali. Il limite fisico incide sulla possibilità di avere rapporti sessuali soddisfacenti come sovente lo si era inteso sino ad allora in termini di prestazione. Più si percepisce il timore e la paura di essere considerati dal partner malati e maggiormente limitati rispetto al passato, più si teme di essere rifiutati, oppure accettati per una sorta di compassione, o pena. Chi ai rapporti sessuali sino ad ora aveva associato l’idea di prestanza ed efficacia sessuale, si trova a dover rielaborare il proprio modello: il cambiamento ed il decadimento fisico spaventa e non lo si vuole mostrare nell’intimità all’altro, anche se compagno di una vita. Di fronte a questo quadro, si pongono al paziente e al partner alcune questioni di fondo: La qualità e le modalità di vivere la sessualità modificata all’interno della relazione affettiva Il senso del limite nella quotidianità Il senso del tempo nel rapporto Il significato della libertà nel momento in cui ci si sente più costretti, più condizionati (da limitazioni corporee, dal dover integrare un elemento come la stomia), più dipendenti Il significato della sessualità che è più ampio dell’avere rapporti sessuali Come vivere aspetti della propria creatività, fantasia, gratificazione, dell’equilibrio, dell’appagamento affettivo, quando i limiti sono notevoli nella possibilità di svolgere le normali attività rendendo problematica la relazione con il partner ed imponendo difficoltà consistenti nel rapporto di coppia Quale potrebbe essere una riposta costruttiva della persona di fronte al limite Come cambia la propria identità in relazione alla malattia ed ai cambiamenti corporei La sessualità potrebbe essere energia da recuperare e sviluppare al fine di affrontare la propria storia, il proprio qui ed ora. Nella nostra società e cultura attuale viviamo in un ambiente nel quale la figura emergente ed imposta è quella del “consumatore” a tutti i livelli: è importante che le persone siano dei consumatori di qualunque cosa, in questo...
read moreL’importanza di sentirsi qualcuno
Con il termine conformismo o conformità si fa riferimento a una tendenza ad adeguarsi a opinioni, usi e comportamenti già definiti in precedenza, E’ una condizione che potremmo definire “la miseria psicologica della massa”. L’origine del conformismo risiede nella radice animale dell’essere umano che attinge le sue paure dalla solitudine fuori dal branco. È una sorta di comportamento mimetico: l’individuo si nasconde nell’ambiente sociale nel quale vive, assumendone i tratti più comuni, in termini di modi di essere, di fare, di pensare. Il senso di protezione che ne deriva rafforza ulteriormente i comportamenti conformisti. Questo pericolo incombe maggiormente dove il legame sociale è stabilito soprattutto attraverso l’identifiazione reciproca dei vari membri, cioè ognuno si rispecchia nell’altro e in questo rispecchiamento si cerca di cogliere solo gli aspetti vincenti e di valore per quel gruppo di riferimento, quindi la nostra società si è strutturata in vari gruppi: giovani, adulti, uomini, donne, singles e corporazioni, è una sorte di selezione a strati, uno contro l’altro, dettati dalla forza contrattuale e da interessi egoistici individuali che vengono supportati dall’interno del singolo gruppo d’appartenenza. Gruppo contro gruppo. Da tutto questo nascono i pregiudizi e gli stereotipi. Il pregiudizio altera l’esame di realtà e l’esperienza, è come un’ombra che ci precede e che può essere l’origine di tanti comportamenti discriminatori, spesso nei confronti dei gruppi socialmente più fragili (anziani, giovani, malati, extracomunitari: il “diverso” rispetto il gruppo di potere) che penalizza la singola persona che non viene valutata per quello che è, ma per l’appartenenza al gruppo o alla categoria. Il pregiudizio nasce anche dalla rimozione sociale “occhio che non vede cuore che non duole” e da quello che in psicoanalisi viene definita Identificazione Proiettiva, “cioè vedo la pagliuzza negli occhi degli altri e non vedo la trave nel mio occhio” attribuisco un giudizio negativo all’altro per non fare i conti con i miei in me stesso Mentre lo stereotipo è un tipo di pensiero rigido, ingessato e generalizzato con orientamento al passato e chiusura al cambiamento. Così avviene nella nostra società nei confronti degli anziani. Infatti la vecchiaia è sinonimo di: decadimento – malattia – inverno e crepuscolo – i vari sintomi psicofisici che insorgono l’età avanzata vengono subito interpretati come inizio di una patologia neurologica senile. La nostra società del tipo consumista è caratterizzata dalla soddisfazione immediata dei bisogni, del piacere e dall’assenza del limite “perché no” proprio come nel paese dei balocchi di Pinocchio. Tutto questo intasamento ed eccesso di godimento si scontra però con la realtà della vita quotidiana che invece è caratterizzata dal limite che invece esiste in Natura, nel Corpo Umano e quindi nella Salute e nella Malattia , nella decadenza e della Morte. La conseguenza è la negazione della vecchiaia e l’isolamento dell’anziano, e quando l’essere umano invecchia o si ammala gravemente è costretto in un profondo isolamento sociale , con un grande senso di solitudine, una specie d’eutanasia d’abbandono. In questo conformismo si comunica tendenzialmente per estremi: bianco-nero, buono-cattivo, freddo-caldo, forte-debole perché non si tollera la fatica di un giudizio fatto di sfumature, fatto di riflessioni soggettive, ma si mette solo la crocetta su vero o falso per rispondere ad una domanda del compito. Nei confronti dell’anziano vi è un pensiero culturale massificato del tipo: tanto non ci arriva!…..non è vero ha solo bisogno di più...
read moreIntegrazione e gruppalità
Il Cancro è una patologia che disorganizza, invade e distrugge la altre cellule fisiche e psichiche, con l’instaurazione della paura che é un grosso peso per il paziente ed un inquilino invadente dentro la casa, e rappresenta una minaccia per la dare una risposta a questo disagio globale, ho strutturato il mio intervento clinico ad indirizzo psicoanalitico, utilizzando la gruppalità come sonda di conoscenza e come strumento terapeutico; privilegiando l’aspetto integrativo per cercare di riorganizzare quello che la malattia ha disgregato, facendo i conti con i limite dei fattori istituzionale dove io opero. La lettura bioniana delle mie dinamiche e di quelle dei pazienti in gruppo, ci ha permesso di condividere l’esperienza del trauma e della separazione, attraverso il ricordare, e ri-elaborare e rappresentare un’esperienza angosciosa senza nome, allo scopo di stimolare l’utilizzo e l’aumento della pensabilità, individuando potenzialità mai precedentemente conosciute (capacità negativa di W.Bion). Così come hanno fatto i nostri emigranti in terra straniera, quando sconfortati si sentivano perseguitati da Dio e dal destino. La figura dello psicoanalista si colloca in una zona di frontiera tra la medicina e l’antropologia della salute. Colui che conosce le due lingue, una delle quali a lui straniera, conosce anche le culture diverse per capire gli assiomi e le sfumature. Quindi si colloca tra l’oncologia e la psicologia, è uno psicoterapeuta che opera in un’altra sede (l’oncologia) con il suo sapere (psicoanalisi)) per facilitare un cambiamento attraverso un processo semantico, cioè la ricerca del senso. Vi è una grande difficoltà da parte dei pazienti ad accettare la proposta di partecipazione ad un gruppo terapeutico, poiché vi è spesso la richiesta di un rapporto individuale di stile maternage; inoltre la nostra cultura non facilita la condivisione in gruppo, poichè basata sulla diffidenza da tutto ciò che è estraneo all’ambito famigliare. Per queste ragioni è sconsigliabile la partecipazione in gruppo a persone in fase diagnostica, pre-operatoria o terminale, la presenza di pazienti con recidiva va sempre confrontata nell’economia del gruppo nella sua globalità, mentre il gruppo ha un gran valore terapeutico come strumento riabilitativo. Ho privilegiato il setting gruppale per le sue specificità di: rispecchiamento dove la sofferenza, oltre ad essere percepita e trasmessa intersoggettivamente, viene anche trasmessa con la comunicazione del corpo, e quindi meglio capito e supportato dalla condivisione con gli altri, così perfettamente definita da F. Corrao come koinoinonia . Ed anche per ridurre l’utilizzo dell’identificazione proiettiva dei pazienti poiché possono sperimentare in gruppo la reciprocità nel vedere nell’altro i propri aspetti evacuativi inconsciamente. I componenti del gruppo possono rappresentare i fantasmi insiti in ognuno di noi: che possono essere ascoltati, compresi ed attraversati dall’esperienza condivisa e guidata dal conduttore, che permette ai componenti di potersi confrontare; stimolando lo scambio di una visione binoculare :essere ammalati nel corpo-mente, nella prospettiva di mantenere una correlazione della patologia in una relazione mentale e fisica, dove entrambi coabitano, così come avviene con l’inconscio e la coscienza. Il gruppo quindi come strumento privilegiato per uscire da uno stato di sofferenza che tenderebbe all’isolamento, in direzione di una palestra protetta, prima di affrontare il “mare aperto” del sociale. Il gruppo anche come strumento centrifugo per accelerare i tempi e i vari punti di vista e per facilitare l’integrazione di emozioni e pensieri e rimuovendo il vecchio schema mentale nell’utilizzo di categorie rigide come: bene/male buono/cattivo,...
read moreRestituire significato alle emozioni
La diagnosi di tumore è un trauma, spesso ne consegue la scissione come difesa dal vissuto di impotenza, una parte scissa del sé corporeo: la rappresentazione di una bestia che si insinua nel proprio corpo, causando degrado fisico, associato ad un dolore che consuma il corpo e fa impazzire la mente. La malattia la si percepisce mostruosa quando i suoi effetti sono visibili all’esterno, soprattutto sul volto, oppure agli organi associati alla sessualità. Noi occidentali siamo attratti dalla bellezza, alla ricerca dell’armonia e dell’asimmetria dei tratti somatici, ne consegue una sensazione di completezza ed equilibrio. Leonardo da Vinci è l’artista che meglio ha rappresentato questo concetto dove ogni organo era perfettamente disegnato e adatto allo scopo. Invece siamo turbati dall’asimmetria soprattutto nei tratti del viso, più di altre parti del corpo perché richiede una risposta emotiva più pesante, poiché richiede di tollerare le differenze e in definitiva la nostra finitezza. La bruttezza è spesso percepita come cattiva e maligna, proprio come nel romanzo Frankenstein, in cui il protagonista, la Creatura del romanzo di Mary Shelley, suo malgrado è stato creato brutto, ma è diventato anche cattivo come reazione alla non accettazione da parte del suo creatore. Ciò che è brutto viene avvertito anche come pericoloso, da cui prendere le distanze, perché è un pericolo per il nostro sé, poiché la bruttezza è qualche cosa che noi non riusciamo ad integrare nella percezione di noi stessi e che depositiamo nell’altro percepito-come-brutto. Pertanto noi siamo attratti anche dalla bruttezza e dai brutti, perché depositiamo in loro le nostre- parti- brutte e ci allontaniamo da loro attraverso la scissione e la proiezione nell’altro, lontano da noi. Da qui l’etimologia della parola mostruosità, che deriva da mostrare, mettere fuori, qualche cosa che è scomoda da tenere dentro nella percezione di sé. Per queste ragioni il malato oncologico si sente discriminato, stimola imbarazzo e vergogna verso se stesso e verso gli altri, così come è stato ben descritto nel romanzo La Metamorfosi di F. Kafka, quando descrive i pensieri depressivi e angosciosi di Gregorio Samsa, quando svegliandosi una mattina si ritrova nel corpo di uno scarafaggio. Il dolore oncologico lo si può codificare come fisico, psichico, sociale, quindi globale. Sempre associato alla paura che diventa un co-inquilino della propria esistenza, si susseguono vissuti di perdite sociali con la sensazione di emarginazione, percependosi un peso per sé e per la propria famiglia. L’insieme e la sommatoria di questi aspetti creano una sofferenza, che viene percepita come annichilente, perché portatrice di cattive aspettative che ostacolano il mantenimento di un atteggiamento vitale di...
read moreLa “giusta” visione del lutto
Intervista di Alessandra Cicalini In una società priva del senso del limite, la morte è un evento accidentale, difficile da metabolizzare. A dirlo, è Luigi Valera, psicologo-psicoterapeuta consigliere nazionale della Società italiana di psiconcologia (in sigla, SIPO), socio fondatore nonché membro del Comitato scientifico dellaVidas, l’associazione nata in Lombardia nel 1982 con il principale scopo di dare una mano alle famiglie ad affrontare in maniera consapevole la malattia e la sofferenza. “Inizialmente eravamo un movimento filosofico-culturale – racconta Valera – animato da un nucleo di volontari e da alcune crocerossine che si affiancavano ai medici ospedalieri per combattere l’isolamento del malato terminale”. Nel tempo, la Vidas è cambiata, com’è mutata, del resto, anche l’Italia. Da una parte, sono aumentati i servizi, offerti a domicilio o in “hospice”, la struttura dell’organizzazione che accoglie l’ammalato e il proprio familiare nei giorni dell’addio. Dall’altra parte, è diventato più frequente il ricorso alle sedazioni, anche su richiesta degli utenti stessi. “Oggi ci si chiede di togliere il dolore”, spiega ancora lo psicoterapeuta, “mentre noi originariamente volevamo togliere la sofferenza”. Come andare oltre questa dicotomia? La risposta nell’intervista che segue. Come è nata la psiconcologia? Dalla necessità di trovare psicoterapie mirate per i pazienti oncologici, troppo spesso vittime di disagi psichici impossibili da diagnosticare con i mezzi della psichiatria tradizionale. Il primo a gettare le basi della disciplina è stato il Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York, seguito da noi dalla Società italiana di psiconcologia. Personalmente, mi sono avvicinato alla disciplina grazie alprofessor Carlo Lorenzo Cazzullo. Com’è cambiata la visione del lutto da quando è nata la Vidas? Da evento naturale è diventato un trauma: anzi, per la precisione di recente è stato inserito tra gli eventi post-traumatici nel quinto manuale Diagnostico statistico dei disturbi mentali (il cosiddetto Dsm5, ndr). Come superare questo tipo di trauma? Con il sostegno di varie figure, compreso lo psicologo, purtroppo considerato un optional di lusso persino dalla legge. In che senso? Pur avendo oggi una legislazione ad hoc sulle cure palliative, non esiste il medico palliatore, inteso come professionista preparato da una scuola di specializzazione universitaria. Per ora, lo si diventa solo dopo master post-universitari o sulla base di molti anni di esperienza. Nella vostra visione originaria, invece, puntavate molto sul lavoro d’equipe? Il nostro motto era proprio: “Nessuno si salva da solo e nessuno può salvare da solo gli altri”. Con il tempo, ci siamo resi conto che era un punto d’arrivo anziché di partenza: ogni professionista è portatore di una sua visione del lavoro e del paziente, percepito solo come proprio. Invece, per aiutare davvero quest’ultimo, bisognava sentirlo “nostro”, passando dalla multi-disciplinarietà delle origini alla interdisciplinarietà. E siete riuscire a compiere questo passaggio? Sì, anche se oggi il tutto si è molto medicalizzato e abbiamo dovuto accettare la logica della sedazione per fronteggiare l’ansia e l’angoscia per la morte. Quindi come lavora la Vidas attualmente? Facciamo molta formazione, proponendo stage di quattro livelli sul “fine vita”. Chi vi partecipa? Il grosso proviene dall’assistenza domiciliare, poi dagli hospice, in particolare infermieri e medici, poi qualche psicologo e assistente sociale. Da dove arrivano? Da tutta Italia: siamo considerati un centro di eccellenza nel settore. A suo avviso, come dovrebbe essere concepito un hospice? E in quale zona della città dovrebbe essere collocato? Per prima cosa, non dovrebbe mai essere una corsia riadattata di un ospedale: si tratterebbe di...
read moreImparare il distacco: Il bambino e l’esperienza della separazione/morte
Pensando al mondo dei bambini spesso riteniamo, o meglio ci piace pensare, che non siano consapevoli della morte o dei problemi che essa pone e quindi evitiamo di prendere l’iniziativa di trattare l’argomento quando si verifica un lutto in famiglia, questo per paura di intristire la loro esistenza con ansia e dolore. Oggi parlare di morte significa affrontare un radicato tabù sociale in quanto ci sono buone ragioni (osservabili) per ipotizzare che sia la madre (o meglio siano i genitori) a proiettare la propria angoscia di morte nel bambino e che questo sia il contenitore, in un primo tempo inconsapevole.(E. Bonasia, Atti del Congresso “Bion Past and Future” 1997). I nostri bambini incontrano spesso la “morte ammazzata” attraverso la televisione dove di solito sono i cattivi a morire e quindi nessuno se ne dispiace veramente , mentre sempre meno partecipano alla morte di un nonno o un familiare .Questo si deve al fatto che i nostri nuclei familiari si sono ristretti e il rito funebre si svolge al di fuori delle mura domestiche. Ecco perchè genitori ed insegnanti dovrebbero cogliere le occasioni per poter affrontare questo aspetto della vita legato ed intrecciato a tutte le altre fasi evolutive, per fornire nuovi dati di conoscenza e stimolare la riflessione, evitando invece racconti paurosi che danno della morte un’immagine distorta. Alcuni psicoanalisti hanno notato come le reazioni di molti bambini ed adolescenti alla morte di un genitore erano inespresse dopo l’accadimento, in quanto” negavano” il carattere definitivo della perdita e vi era ancora l’aspettativa più o meno consapevole di un ritorno del genitore. Oppure si evidenziavano degli acting-out negli adolescenti che sceglievano un’attività professionale o di fede che li portava lontano dal luogo dell’accaduto. Si rivela molto importante per un bambino avere una persona di fiducia per poter esprimere sentimenti collegati alla perdita: insicurezza generalizzata e bisogno conseguente di ritrovarla attraverso un sostituto genitoriale, timore di essere abbandonato anche dal genitore sopravvissuto, collera per la sensazione di essere stato ingiustamente abbandonato e per l’impossibilità di ritrovarlo, infine la tendenza a trovare un capro espiatorio responsabile dell’accaduto e il senso di colpa per un cattivo comportamento. Il senso di colpa potrebbe anche insorgere quando il bambino si scopre capace di ridere e sentirsi felice nonostante l’evento luttuoso. Altra reazione alla perdita è il desiderio di cancellare il tempo presente per vivere nel ricordo positivo del passato (idealizzazione), accentuato negli adolescenti dove vi è un continuo e inconsapevole confronto tra proprio partner e genitore perso. In ogni caso vi è una sensazione costante e generalizzata di non essere capiti nel proprio dolore, del senso di ingiustizia subita ,che possono essere esasperati se continuamente riportati ad eseguire l’esame di realtà. Comunque è importante per tutti esprimere l’intera gamma di reazioni così come suggeriva Shakespeare “il dolore che non parla imprigiona il cuore agitato e lo fa schiantare”. Se la morte è avvenuta per una persona della stessa età, specie se facente parte della famiglia, può spaventare molto il bambino che potrà avere dei dubbi che non oserà esternare “Morirò anch’io?” e “Avrebbero preferito che morissi io?”. Improvvisamente si renderà conto che la morte non riguarda solo i cattivi e i vecchi, ma capita anche ai bambini e ne è molto spaventato e richiede quindi attenzioni e cure particolari. Ultimamente mi è capitato di assistere...
read moreImparare il distacco: dalla separazione alla separatezza
E’ soprattutto la psicoanalisi che si è occupata di analizzare ed interpretare le attività mentali del bambino nei confronti della figura di accudimento: partendo da una impostazione intrapsichica pulsionale (Sigmund Freud) si è passati ad una teoria delle relazioni oggettuali (Melanie Klein), per arrivare a Donald Winnicott che meglio di tutti evidenzia l’importanza del legame tra sviluppo mentale ed ambiente. Egli traccia il percorso di maturazione partendo dalla dipendenza assoluta per arrivare all’indipendenza ,anche se questa non è mai assoluta, in quanto l’individuo interagisce con il proprio ambiente. Tale iter si sviluppa in tre momenti a cominciare dalla dipendenza assoluta che nasce dapprima nella mente della madre che sente il neonato come parte di sé identificandosi con lui, intuendone sensazioni e bisogni. In questa fase la madre potrà permettere il naturale svolgimento del processo di maturazione che Winnicott asserisce già in parte posseduto ereditariamente dal bambino (evoluzione dell’Io, del Sé, dell’Id, delle pulsioni e delle loro vicissitudini). Ma è anche in questo momento la madre dovrà riappropriarsi della propria vita mentale, indipendentemente dai bisogni del neonato, offrendogli la possibilità di sperimentare anche sentimenti aggressivi e cominciare così a sviluppare un pensiero autonomo ,coniugando l’aggressività con l’amore. La seconda fase prevede la dipendenza relativa che permette al bambino un deadattamento graduale dalla madre. In questo periodo che va dai 6 mesi ai 2 anni ,l’infante è consapevole della dipendenza e quindi reagisce all’assenza della madre con ansia, successivamente il bambino avrà gli strumenti per affrontare l’allontanamento da lei. Attraverso l’identificazione con lei prima e con entrambi i genitori poi, il bambino comincia a percepire un interno ed un esterno della pelle, cioè un “me” posto dove conservare le cose e un “non me”. Ora il bambino non è solo un attore passivo, ma anche creatore del mondo con elementi della propria vita interiore. A questo punto egli ha dentro di sé sia le potenzialità per identificarsi con il proprio ambiente sociale con cerchi sempre più ampi, sia l’acquisizione di una capacità di stare da solo. E’ importante il concetto “io sono solo” per la mente del bambino nella costituzione del pensiero “io sono”, in quanto espressione della consapevolezza che egli ha della continuità dell’esistenza di una madre attendibile. Col passare del tempo l’individuo diventa capace di rinunciare alla presenza reale di una figura materna grazie all’istaurarsi di “un ambiente interno”, frutto dell’introiezione, in quanto a poco a poco l’ambiente viene inglobato e strutturato nella personalità dell’individuo che ,aggiunto allo sviluppo di nuove sue competenze, che gli permetterà di essere solo di fatto. “Gli adolescenti si potrebbero definire esseri isolati” continua Winnicott, in quanto strutturano la loro modalità comunicativa allo scopo di proteggere il loro Sé centrale, cioè le scoperte e le conquiste personali che vengono protette prima di essere divulgate e confrontate col mondo degli adulti. Anche la Klein ha affrontato questo argomento sostenendo che la capacità di essere solo dipende dall’esistenza di un oggetto buono all’interno della realtà psichica dell’individuo. Il rapporto con i propri oggetti interni unito alla fiducia verso le relazioni interne, offre di per sé una sufficiente pienezza di vita, così che il bambino sia in grado di sostenere temporaneamente l’assenza di oggetti e stimoli esterni. Melanie Klein si è anche interessata al sentimento di solitudine, il sentirsi solo indipendentemente dalle circostanze esterne. Questa solitudine nascerebbe...
read moreImparare il distacco: introduzione
Lavorando come psicologo e psicoterapeuta spesso mi confronto con problemi che nascono dal passaggio di tappe fondamentali della nostra vita che impongono la rottura di schemi e legami acquisiti per potersi trasformare in nuovi rapporti più consoni alla situazione che si è venuta a creare. Queste tappe sono molteplici nell’arco della vita, iniziano col trauma della nascita e terminano col distacco definitivo che è la nostra morte. Inoltre, nel mio ruolo di responsabile del settore di psicologia presso un servizio di assistenza domiciliare a malati oncologici, spesso sono chiamato ad affiancare il paziente e il suo nucleo familiare nel decodificare, interpretare, affrontare le conseguenze psicologiche che la malattia impone, analizzando le reciproche influenze con particolare attenzione alla presenza di figli minori. Scuole di vario grado hanno richiesto il mio intervento per affrontare i problemi connessi con la realtà della malattia grave (tumore, leucemia, Aids etc..) e soprattutto della morte rivolto a genitori ed insegnanti che si sono scoperti impreparati ad affrontare quello che appare sempre più essere un radicato tabù sociale. Per meglio affrontare il concetto di morte-separazione, ho pensato di collocarlo come evento finale di un lungo processo di costruzioni e rotture dei nostri legami affettivi che si protrae per tutto l’arco della nostra esistenza. L’esperienza del distacco inizia con il trauma della nascita che rappresenta un passaggio violento dallo stato paradisiaco fetale a quello in cui il bambino sperimenta momenti di frustrazione e fatica, anche in seguito alla comparsa di stimoli endogeni ed esogeni che richiedono un continuo adattamento. John Bowlby ha scritto numerosi trattati sull’argomento dove si evidenzia come la coppia genitoriale, ed in particolar modo la madre, rappresenti la palestra dove allenarsi alle continue costruzioni e rotture dei legami affettivi. Gli etologi per primi, attraverso lo studio del comportamento animale (es. l’imprinting) e gli psicologi poi, si sono interessati al fenomeno dell’istaurarsi del legame affettivo (attaccamento) che nasce da uno stato di bisogno e necessita di un punto di riferimento costante individuato nella figura materna a cui potersi affidare . Di conseguenza nell’essere umano è sempre presente la tendenza a strutturare solidi legami affettivi con particolari persone, percepite come più forti od esperte, che possono soddisfare bisogni di vario tipo. Questi rapporti vengono spesso influenzati da esperienze riferite alla primissima infanzia, in particolare a quelle che determinano uno stato di fiducia o sfiducia nella figura di attaccamento e che hanno prodotto l’istaurarsi di difese o anticorpi psicologici inconsci, per proteggersi da ulteriori delusioni o eccessivi carichi emotivi. Anche se particolarmente evidente nella prima infanzia, il comportamento di attaccamento caratterizza l’essere umano dalla culla alla tomba. Le modalità di tale legame variano a seconda dell’età, del sesso, e delle circostanze, e si differenziano dalla dipendenza che non implica un legame stabile ed ha conseguenze fortemente negative. La madre rappresenta la persona che meglio di tutte permette con la sua presenza prevedibile che il bambino cominci ad allontanarsi da lei per poi ritornare, sempre con spostamenti ed assenze maggiori, man mano che aumenta l’età. Bowlby descrive gli atteggiamenti di attaccamento, esplorazione, allontanamento e separazione che si alternano costantemente, e possono essere facilitati dalla coppia genitoriale che rappresenta una base sicura di partenza e di incoraggiamento. Il loro comportamento dovrà essere di disponibilità e comprensione nell’accogliere le reazioni emotive e ciò dipenderà anche dal modo in cui...
read more